A diciotto anni andavo sempre al Mojito, una discoteca di provincia. Ci sono andato per anni. Truzzaglia, risse senza coltelli e soprattutto sbarbe contadine. Ditemi quello che volete, ma una che ti tasta il pacco e domanda “ndemo a ciavar?” arrapa più di qualsiasi giarrettiera. Sarà che sono cresciuto con gli spot del Mulino bianco, mangia sano, torna alla natura e incaprettare la figlia del fattore in camporella ti fa sentire più ecofriendly di qualsiasi prodotto biologico.
Era il 1998.
Appena patentato prendo la macchina dei miei e vado al Mojito da solo, come tutti i ragazzini che possono accedere alla macchina dei genitori per la prima volta. Giri, prendi confidenza col mezzo. Certo Ario il giorno della firma andò in puttantour e finì in fosso, ma erano altri tempi. L’età dell’innocenza. Dio, appena uscito l’euro si riusciva a truffare le negre con le banconote fotocopiate, per dire. I più raffinati col distintivo dell’FBI del piccolo detective incollato sul portafogli chiavavano a sbafo almeno una decina di volte.
Ma non divaghiamo.
Entro al Mojito di straforo, il buttafuori fa palestra da me. L’idea era due birre e a casa, invece è la serata giusta. Una bionda mi guarda, sorride e la raggiungo in pista. Balliamo con la solita tattica del lei che finge che no, poi sì, poi no. Alla fine le offro da bere, parliamo. C’è sintonia. E’ lì con le amiche che son state rimorchiate da altri ed è rimasta al palo. Si smolla. Limoniamo sui divanetti. Tenterei di portarla in bagno ma ho paura di sprecarla. Testo il terreno, allungo appena le mani, mi blocca con quel tipo di “no” che significa “con calma”. Parliamo ancora, beviamo ancora. Le amiche tornano a casa e lei è in macchina con loro. Mi offro di accompagnarla io, dopo. Accetta. Venti minuti e venti chilometri di strada tra fienili e capanne di sterco, poi siamo da lei.
Condominio popolare da abuso edilizio anni ’70, tre e mezza di mattina. Salottino signorile, tappeto sciccoso, divano, televisore gigante, libreria. Limoniamo in felicità sul divano quando una porta si apre e appare suo padre in vestaglia. Non la prende bene. “Se credi di poter fare la puttana”, “hai diciott’anni ti trovi un albergo”, “non porti gente alle tre di mattina” e frasi così. Faccio per andarmene, lui mi ferma. Dice che non posso guidare in quelle condizioni; o dormo sul divano o telefona ai miei genitori che mi vengano a prendere.
Sarà che è più bestia che uomo, sarà che sono effettivamente sbronzo, sarà che lei mi tira un’occhiata tipo “rimani e ci scappa il premio”, resto. So che può sembrare un errore grossolano, ma se un trattore umano ti sgama mentre gli limoni la bimba in salotto di casa nel cuore della notte non è il caso di far questioni. Ho pensato fosse la cosa giusta.
Mi tira un cuscino, due coperte, strattona la figlia e se ne va chiudendo la porta della zona notte a chiave. Se hai un adolescente sbronzo in salotto e una figlia che spruzza feromoni in camera non lasci la porta aperta, giusto per evitare la trafila dell’aborto a pugni. Mi metto sul divano.
Chiudo gli occhi.
Tutto gira.
Mi viene da vomitare.
Cerco il bagno ma la zona giorno è composta solo da salotto e cucina. Il grezzo s’è barricato a difesa di tutti i buchi della casa, water compreso. I conati si fanno più pesanti. Apro la finestra del salotto, guardo giù e c’è una panetteria aperta col fornaio che fuma. La finestra della cucina è troppo alta. Non ce la faccio più, corro verso la porta d’entrata ma BRAAA, dal naso, dalla bocca, dagli occhi, espello tutto sul grazioso parquet. Resto ansimante con la gola riarsa e un cacaio sul pavimento. Il panico si impossessa di me. Devo far sparire quella roba al più presto, ma con cosa?
Non è casa mia.
Non so dove mettere le mani.
Lì per lì, l’immancabile foto di famiglia in bianco e nero sul mobiletto d’ingresso mi pare l’idea migliore.
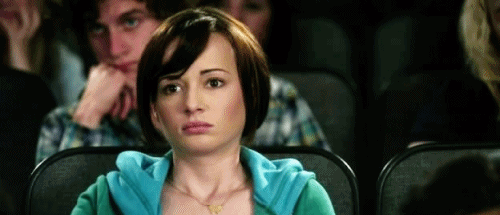
C’è sempre. Famiglia al completo col vestitino della domenica, espressioni sognanti di un futuro prossimo come la ripresa economica. Tolgo la cornice di finto argento e uso la foto a mò di paletta. Funziona egregiamente. Mentre spatolo realizzo di non sapere dove metterli. Provo a fare andata e ritorno fino al lavabo della cucina, ma spando trasformando il pavimento in un lago di succhi gastrici. Disperato, afferro il cassettino del mobile e lo uso come secchio. Il tanfo è mostruoso e solo sentirlo mi fa sboccare ancora, questo giro direttamente nel contenitore perché ormai tanto vale. Vorrei disperarmi ma sorge un secondo problema: crampi da diarrea post sbronza. Il culo s’è innescato e sta per esplodere, ma dove?
Il cassettino è oramai ricolmo.
Mi sporgo dalla finestra del soggiorno e glasso il panettiere? Una pioggia di merda desta sospetti anche negli individui più primitivi. Potrei tempestare di pugni la porta della zona notte urlando al mondo la mia vergogna. Essere un signore, cacare sul pavimento e deglutire l’orrore a cucchiaiate. Me ne manca il coraggio. Piegato in due dal dolore giungo in cucina, apro lo sportellino sotto il lavello dove tutti tengono il cesto dell’immondizia e ci cago dentro. E’ come se l’inferno avesse ghermito le mie natiche, le avesse spalancate e decine e decine di dèmoni le avessero varcate per seminare morte. Il rombo mi squassa. Aria, acqua, terra e fuoco si fondono per attraversare il mio timbramutande e obnubilano il tanfo della monnezza, soverchiandone l’afrore. Tutto è squallore e rovina, ma sono salvo.
Posso farcela.
Gli ho trasformato il salottino nelle stanze di Hostel, ma posso farcela.
Certo, lì per lì non penso che il mobiletto con la sorpresina non si sarebbe autodistrutto e che quando papizappa l’avrebbe aperto per cercare le caramelle di nonnina avrebbe trovato Sarlacc del cazzo, ma ero molto ubriaco. Devo liberarmi del figlio di Satana che ho partorito e dedicarmi alla pulizia, ma siamo al sesto piano. Chiudo il sacchetto della monnezza, decido di scagliarlo dalla finestra della cucina ma è alta, non so cosa c’è sotto e temo l’omicidio colposo. Allora vado dall’altra parte, il fornaio non c’è più. Se lo lascio cadere finisce in strada, ma giusto dall’altra parte c’è un boschetto di cespugli. Devo tentare il lancio tipo bolas. Inizio. Faccio un giro, due giri, al terzo il sacchetto cede con uno schiocco, si squarta a parabola giusto mentre l’orbita attraversa il salotto e un uragano immondo dipinge la parete, la libreria, il televisore, il tappetino, i muri, lo specchio.
Non oso girarmi.
Aspiro l’aria della notte, conscio che alle mie spalle si è consumato il dramma. Il sacchetto squarciato mi penzola dalla mano, vuoto involucro dei miei incubi peggiori che gocciola gli ultimi rimasugli dell’innominabile. Senza nulla dire, il mio viso si contorce in una smorfia di dolore. Piango come un condannato che guarda il muro della fucilazione.
Mi volto.
E’ l’armageddon.
Gusci d’uovo putrefatto sulla tovaglia ricamata, assorbenti usati tra i libri, scatolette di tonno, fazzoletti sporchi, lische di pesce sul ventilatore, piatti di plastica unti sul tappeto, diarrea che gronda dal soffitto. Non v’è rimedio. La casa va demolita, le macerie sparate nel Sole. A essere un uomo aprirei il gas e mi farei detonare con la famiglia, ma me ne manca il fegato. In un ultimo atto di pietà piego con cura le coperte miracolosamente immacolate. Sono tentato di lasciare un biglietto ove spiegare tutto, ma nessuna parola vale il rischio di lasciare le mie impronte digitali. Getto un’ultima occhiata al mobiletto contenente i drink della serata, poi apro la porta e me ne vado per sempre.
Da allora smisi di frequentare il Mojito. Il buttafuori disse che la polizia andò a fargli qualche domanda. Lui fu evasivo, data la mole di erba che si fumava grazie alle piantine di Ario. Io preferii vagare nelle tenebre della notte e fare il writer, dopotutto avevo un talento innato nel pitturare muri. Ecco perché le dico che da qualche parte qualcuno vuole uccidermi, dottoressa»
La psicologa della scuola tiene la bocca semiaperta.
«Dice che sono pazzo?» chiedo.
Non risponde.
