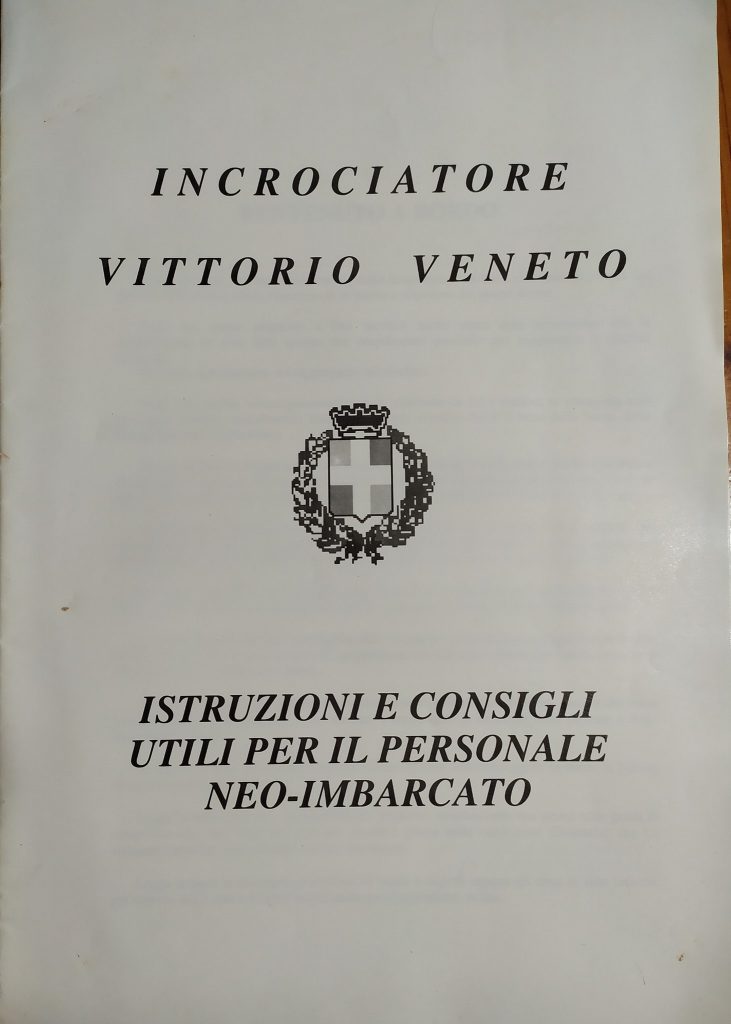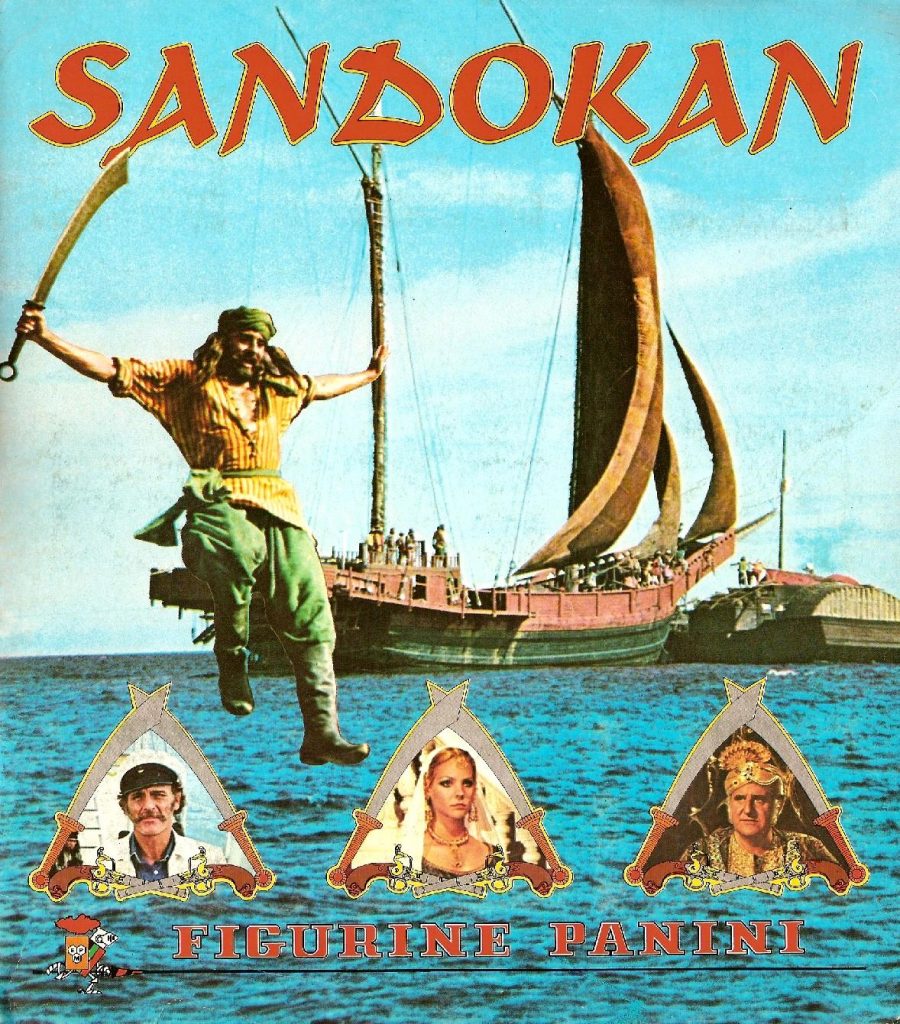3 luglio 1979, ore 11.20
L’interno del Vittorio Veneto erano corridoi con troppi strati di vernice verde chiaro e pavimenti di linoleum nero. Sopra le loro teste si dipanavano tubi e cavi di ogni forma e dimensione. Scesero la scaletta dal ponte di coperta prora, passando di fianco alla camera di caricamento dei cannoni e scendendo nelle viscere di metallo. Gli odori si alternavano: detersivo per pavimenti con retrogusto amarognolo nei locali angusti, puzzo di sudore nei corridoi di passaggio. I ventilatori sui soffitti e sugli scaffali spostavano aria calda e umida senza generare alcun beneficio. Dopo aver toccato un paio di sostegni, le mani di Domenico erano già secche per la salsedine.
«Vado ora a iniziare la lezioncina su come funziona a bordo» disse Mario.
Domenico schivò due uomini a torso nudo che spostavano un grosso cavo nero. Passarono di fianco a una parete da cui proveniva un frastuono meccanico che lo costrinse a urlare: «Prima vorrei capire dove sono!»
«Sull’incrociatore lanciamissili Vittorio Veneto, amigo!» gli urlò Mario con occhio spiritato «La nave ammiraglia della Marina militare italiana: 73,000 cavalli vapore di maschia potenza e un sacco di tecnologia d’avanguardia, almeno se paragonata alle caravelle di Cristoforo Colombo. In questo momento sei due piani sotto il ponte di coperta prora. Tu dormirai qui» disse, indicando una botola sul pavimento. Davanti era incisa la targa INCR.V.VENETO.
«Ricordati il nome: alloggio 3.»
«Alloggio…? Lì sotto?»
«Avresti dovuto averne uno più bellino, ma quelli di noi sottufficiali sono stati riconvertiti in una seconda infermieria, quindi c’era poca scelta. All’alba gusterai il megafono di Capo cannone, dato che siamo vicini alla camera di lancio. Ora scendi che devo scorreggiare.»
«Oh, Dio.»
«Non temere, giallastro amigo, questi sono posti extralusso. C’è il locale 5 che fa 80 posti letto e ha seri problemi di ricambio aria, afrore di piedi a mille, ascelle atomiche, svenimenti. Sta vicino al locale agghiaccio timoni. Poi c’è il locale 6, che è a poppa sotto il giardinetto. Un paradiso, infatti ci dormo io. Il peggio è il locale 8 a poppa, giusto di fianco alle assi delle eliche. Un concerto di cuscinetti e assi che ad alcuni concilia il sonno, ma alla maggior parte conduce alla pazzia. Riescono a dormirci solo quelli della Mano nera.»
Domenico alzò un sopracciglio: «I fascisti?»
«Nah. Meccanici. Caldaisti, elettricisti, tecnici. Gente con le mani nere, appunto.»
Gli consegnò un paio di scarpe da ginnastica, una maglietta bianca, una camicia azzurra e un paio di pantaloni blu, più un tesserino da appuntare al petto con una pinza. Sul grado c’era scritto un semplice “interprete”, poi un quadrato colorato di bianco, una sua foto presa dalla carta d’identità con il timbro della Marina, lo spazio per cognome e nome su cui qualcuno aveva scritto in bella calligrafia Domenico Figgh-En-Drocch. Era difficile dire se l’autore fosse stato spiritoso o distratto. L’ultima cosa che gli venne consegnata era un opuscolo fotocopiato male di dodici pagine, intitolato
Provò a leggerlo, ma Mario era già ripartito e lui dovette corrergli dietro.
«Ora, devi sapere che qui dentro chiunque è indispensabile. Il cuoco di bordo come questa burba infame» disse Mario, menando un coppino a un marinaio che passava con in mano un cassone grigio. Quello proseguì come niente fosse. Mario, facendosi largo in quel costante viavai di uomini e merci, spiegò per sommi capi gli orari. La sveglia era alle sei e mezza, bisognava rifare il letto e alle sette presentarsi in sala mensa per colazione. Si avevano quarantacinque minuti per espletare le proprie funzioni fisiologiche e fare le abluzioni, poi bisognava presentarsi alle otto meno un quarto alla pre adunata.
«Se stai per fissarmi con l’aria dell’intellettuale introverso e confuso ma con un cuore grande così, ti fermo» disse Mario «Pre adunata vuol dire che hai un quarto d’ora di ritardo massimo per arrivare all’alzabandiera, poi punizioni corporali, botte, frustate.»
«Come il quarto d’ora accademico» annaspò Domenico, schiacciandosi contro la parete per evitare tre uomini che portavano dei sacchi. Perse l’equilibrio e finì contro il muro. Mario lo aiutò a rialzarsi: «Niente parole omosessuali a bordo.»
«Perché accademico sarebbe omosessuale?»
«E io che ne so» disse Mario, ricominciando a camminare.
Dopo l’alzabandiera i lavori a bordo cominciavano alle otto e un quarto.
Domenico scoprì che avrebbe ricevuto i propri compiti dagli ufficiali, quindi non aveva mansioni fisse. L’avrebbero chiamato dove serviva. Alle dieci e mezza c’era una pausa in cui si poteva andare allo spaccio, stare in cambusa o fare uno spuntino. Si ricominciava alle undici fino all’una e un quarto, quando ci si preparava per il rancio. Un’ora di pausa pranzo e si ricominciava fino alle sei, poi si andava in franchigia fino alle nove. Quando Domenico chiese cosa significasse quella parola, Mario fu lapidario: «Scendere nave, inserire alcolici, scopare puttane. Se invece sei in mare, filmetti e seghe. Per quelli come te ci sono anche i libri.»
Era a bordo da meno di un’ora e già non sopportava quel marinaio. Era l’opposto delle persone che aveva sognato di frequentare quand’era a Strassoldo. Grezzo, diretto, volgare, pieno di pregiudizi e con quell’atteggiamento da padrone di casa che aveva visto soltanto negli americani conosciuti a Trieste. Era curioso di conoscere gli ufficiali, per vedere quanto somigliassero ai ritratti dei film di Gian Maria Volontè.
«Dunque? Pronto a morire combattendo i pirati della Malesia?» domandò Mario.
«C’è pericolo?» chiese Domenico, sperando di non far trasparire la paura.
«A bestia. Queste navi sono fatte per il Mediterraneo, non per l’oceano. Inoltre ci andiamo nella stagione peggiore; quindi tifoni, maelstrom, tentacoli giganti. E poi sì, claro che c’è Yanez con la sciabola.»
«Ma… Sei serio?»
«Quien sabe? Il mio motto è pensa sempre al peggio: se accade non ci resti male, se va bene sei felice.»
Chi me l’ha fatto fare, pensò Domenico, e Mario sembrò leggergli nel pensiero.
«Sei qui perché un uomo non resiste al richiamo dell’avventura, specie se conduce una vita sfighina. La patria chiama, e chi sei tu per sottrarti?»
«Io non ho spirito di patria. Sono un cittadino del mondo.»
«Devi parlare potabile, amigo, o mi partono le sberle traduttrici.»
«Per me i confini non esistono. Siamo tutti fratelli. E io voglio vedere il mondo, conoscerli, non fermarmi per colpa di qualche linea immaginaria.»
«Scoprire e scopare, grande filosofia.»
«Io non ho detto questo!»
«Ma sì, gringo, è palese l’intento: tu vuoi presentarti con lo sputafigli di fuori dove non ti conosce nessuno, fare due foto, trapanare qualche fighino e fuggire senza pagare. E lo rispetto, è una maschia missione. Il problema sono i padri delle squinzie. Bastonarti diventa la loro missione di vita, ti braccano per assassinarti. Ma grande è la ricompensa, certo. C’è un motivo se buona parte delle burbe qui attorno avrebbe potuto sbarcare, ma si sono offerti volontari.»
Domenico corrugò la fronte. Tralasciando l’interpretazione animalesca della sua frase, era straniante pensare che ogni ragazzo attorno a lui, invece di tornare a casa, avesse preferito rischiare la pelle per salvare degli sconosciuti. Le facce che gli passavano davanti erano sbarbate e innocenti come le matricole dell’università, ma a differenza dei suoi compagni di corso sembravano felicissimi. Si accorse che Mario proseguiva senza di lui e gli corse dietro.
Arrivato al proprio alloggio si fermò, guardando marinai che accatastavano montagne di viveri. C’era più pastasciutta che in un supermercato, e casse di verdure continuavano ad arrivare e scomparire dietro altre porte. L’atmosfera gli ricordò la cascina di suo nonno quando s’era sposata una nipote. Lui era piccolissimo e giocava in cortile, correndo tra le gambe di uomini e donne che sistemavano fiori, portavano viveri e preparavano un grande tavolo in giardino, con i quattro pastori tedeschi che abbaiavano e saltavano senza capire niente, i gatti stavano sulla finestra a prendere il sole e le scarpe si sporcavano dell’arancio delle albicocche lasciate a marcire nell’erba. Poi quelle feste avevano smesso di colpo. Forse i nonni si stancavano, o forse la politica aveva infettato anche i nuclei familiari.
Si tastò in cerca di una penna per correggere il nome sul tesserino, e trovò la biro che gli aveva prestato quel tizio in aereo. Era una Bic gialla, sul cui fianco era stampato l’indirizzo di una pizzeria di Trieste. Se la rigirò in mano, quasi a cercare qualche trucco come nei film di James Bond. Era soltanto una biro. Gli tornò in mente Alfio. Avrebbe potuto vederlo seduto di fianco a lui in una pizzeria, o in corriera e non gli sarebbe mai passato per la testa che appartenesse al SID, o come si chiamavano adesso i servizi segreti. Anche a parlarci somigliava a un mezzo malavitoso, o a uno dei tanti slandroni che sentiva pontificare dai tavolini dei bar. Quelli che tra una birra e una sigaretta inneggiavano a colpi di Stato e fischiavano dietro alle studentesse di passaggio come lupi impotenti. Alfio invece stava su un volo di Stato assieme a tonnellate di grana e a due africani in costume tradizionale, diretto chissà dove e a fare chissà cosa.
Il fatto che sembrasse un uomo così comune, anzi improbabile, forse lo rendeva ancora più sinistro. Aveva ragione Poe: il miglior nascondiglio è sotto gli occhi di tutti. Anche i ragazzi che strascicavano i piedi attorno a lui erano quei tipi qualsiasi, stanchi e svaccati, che potevi trovare in uno spogliatoio.

Si spogliò, gettò il completo beige e la camicia sulla branda e s’incamminò in mutande verso i bagni, facendosi largo tra altri ragazzi indaffarati. Si diede una rinfrescata e indossò quello che gli era stato dato: camicia azzurra e pantaloni blu. Rimase a guardarsi allo specchio, ascoltando battute e risate degli altri, ognuno con un’inflessione dialettale diversa. Aveva già vissuto quella stessa situazione durante la visita. Erano posti dove il cervello taceva, troppo impegnato ad analizzare ed elaborare informazioni per produrne di proprie. Osservava e ascoltava, incuriosito dal vociare, la frenesia e lo scricchiolare metallico delle fiancate.
«Sei bellissimo» disse Mario all’ingresso. Domenico sorrise e lui gli tirò una pacca sulla spalla: «Scherzo, stai una merda, ma va bene così. Adesso vamonos, ti mostro quello che devi sapere della nave.»
Domenico riprese a correre dietro il marinaio attraverso stanze e corridoi, più spaventato all’idea di perdersi che di memorizzare quello che gli stava dicendo. C’era troppa confusione, troppa gente, troppi ostacoli e troppo rumore. Sbucarono a poppa, in uno stanzone che dava sul ponte di volo. La vista dell’aria aperta quasi lo accecò. L’hangar era stato diviso a metà. Sulla sinistra, una fila di letti a castello stava venendo ordinata da ragazzi a torso nudo e l’aria di chi su quei letti ci si sarebbe disteso volentieri. A destra c’erano attrezzi da meccanico ammassati alla bell’e meglio.
«Questo è l’hangar» fece Mario, allargando le braccia «Ci dormiranno donne e bambini. Una volta in mare, qui potrà entrare solo il comandante, il personale di volo, i segaossa e forse voi interpreti. Poi ovvio che andrà tutto in vacca, ma gli ordini sono questi.»
Separare le famiglie pareva un atto di crudeltà, invece era l’unica scelta intelligente. Era stata pianificata dagli ufficiali che ben conoscevano la vita in mare. Fin da prima della scoperta dell’America si diceva che una donna a bordo di una nave portasse sfortuna. Il motivo era prosaico quanto concreto: i viaggi duravano anni, e i marinai finivano a contendersi l’unica donna a coltellate. Questo creava un clima cupo che sfociava in insubordinazione, ammutinamenti e tragedie. Per assicurarsi che il concetto entrasse nelle menti più semplici si optava per il paranormale, quella Dea fortuna bizzosa e irrequieta che nessun uomo di mare avrebbe mai osato infastidire. Sul Veneto avevano preso la stessa decisione: i maschi sarebbero rimasti a dormire negli alloggi di prua, le donne e i bambini a poppa.
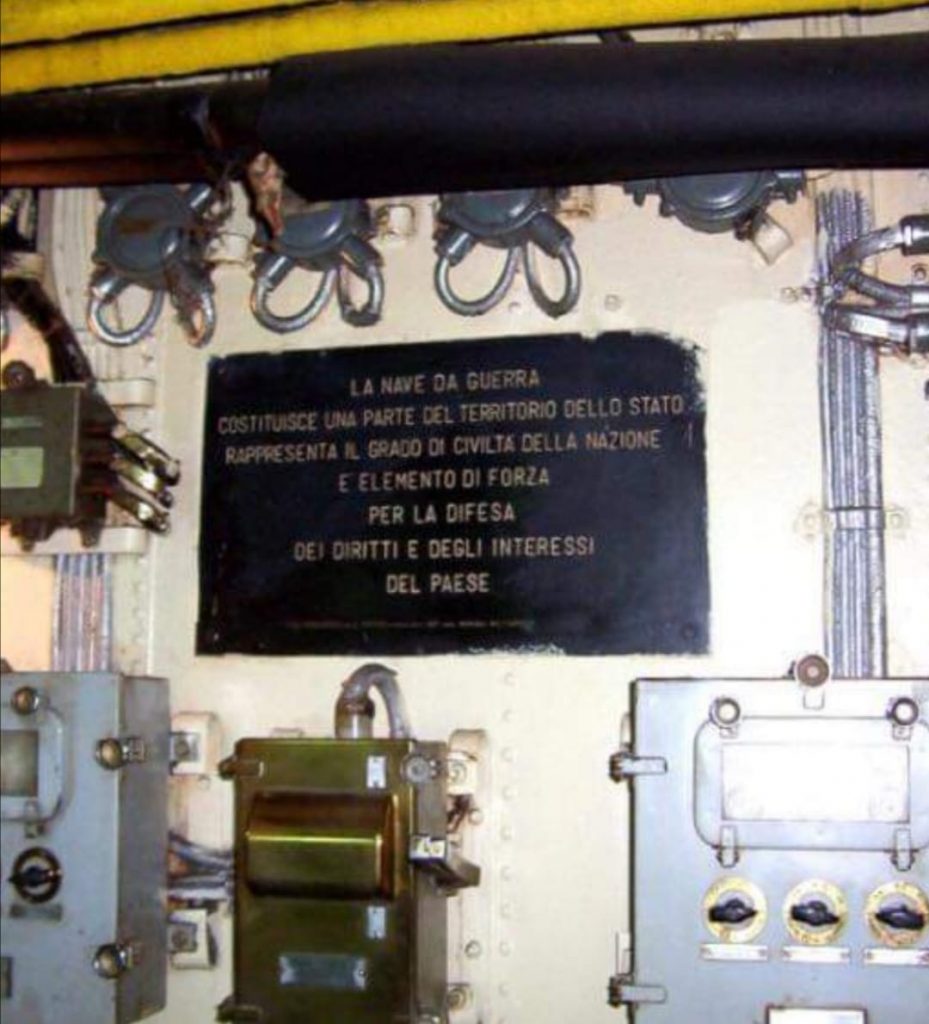
Scesero una scalinata e si trovarono sotto il ponte, dove le murature esterne – reti metalliche – erano state chiuse per trasformarlo in sala ricreativa. C’erano pacchi di acqua minerale, succhi di frutta, sacchi di riso e montagne di vestiti che venivano separati e ordinati. Quando uscirono sul ponte di volo, Domenico restò allibito. Rispetto ai locali angusti della nave, pareva grande e lungo come un campo da calcio. Avrebbero potuto starci quattro elicotteri. L’ultima tappa fu la plancia. Appena si trovò davanti alle vetrate notò un brusco cambio d’atmosfera. Le uniformi erano più in ordine, le schiene dritte e le parole più misurate. C’erano macchinari, indicatori e tubi che sparivano nel soffitto, blocchi grigi di apparecchiature fissati a paratie biancastre e pavimenti di linoleum verde su cui buona parte dei marinai stava in piedi, armeggiando tra carte e altri indicatori. Gli venne presentato il quadro ufficiali e sottufficiali composto da uomini in bianco con occhiaie e palpebre che si abbassavano troppo lente, ma si sforzavano di essere cordiali.
Scordò nomi e gradi l’istante dopo averli sentiti.
Arrivata l’ora di pranzo aveva la testa che gli scoppiava. Più che appetito, sentiva un disperato bisogno di rimanere solo. Ogni angolo della nave era un delirio schizofrenico di uomini, merci e ordini. Chiese a Mario di tornare in cabina, ma quello scosse la testa: «A bordo di una nave militare si sta coi gringos. Si lavora, si parla e si gioca sempre in batteria. Si isolano sulle mercantili, sai. Moldavi, italiani, filippini stanno in camerino 20 ore a segarsi ed escono solo per lavorare. Appena qualcosa s’introia diventa una lotta tra bande. Qui ci sono pure armi, quindi diventerebbe mezzogiorno di fuoco. Non se puede. Tutti devono sapere chi sei e a cosa servi.»
A quanto pare la Marina aveva risolto i suoi problemi esistenziali prima di lui: «Nella terra di frontiera…» canticchiò.
«… troppa gente ha paura» gli fece il coro Mario «Vamos, gringo, tra due ora salpiamo per l’altra parte del mondo.»
Salvataggio all’amatriciana, p.39, Salani, 2022